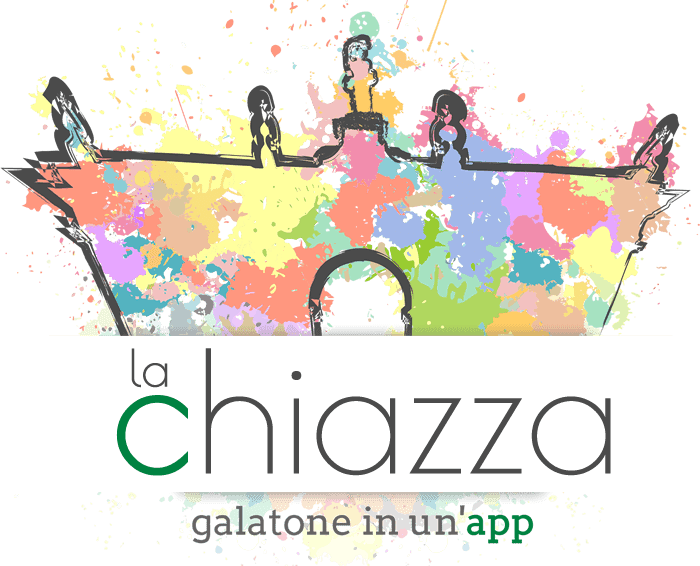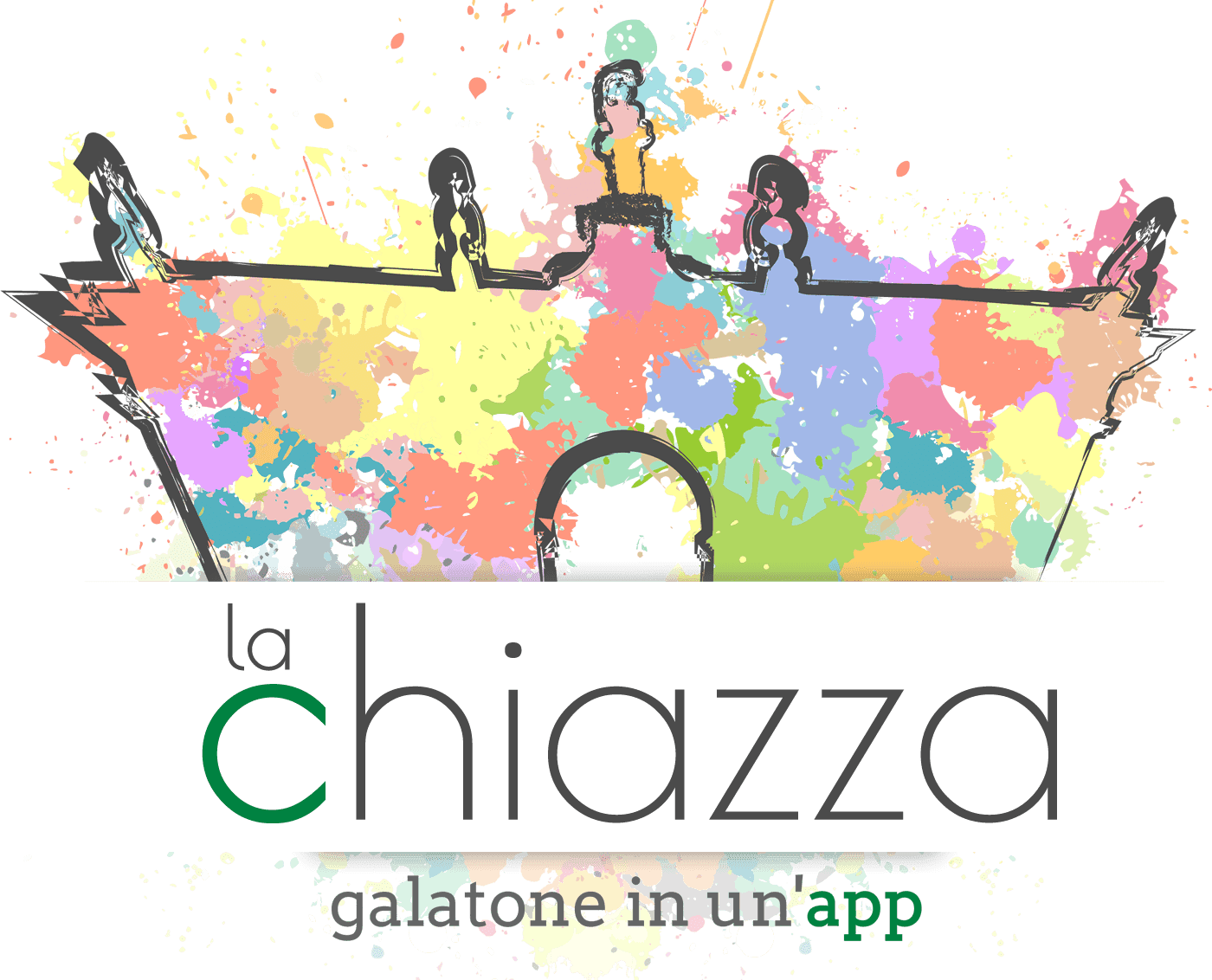Il palazzo marchesale, noto al popolo come castieddu, è un edificio a tre ali dislocato su di una superficie totale di circa tremila metri quadrati, impostato a staffa intorno ad un ampio cortile. Introduce al complesso architettonico il cinquecentesco portale monumentale, sormontato dallo stemma degli Squarciafico. Alla sinistra dell’ingresso, invece, dominando piazza SS. Crocifisso in un elegante pendant con l’omonimo santuario, si erge il possente mastio, la torre Pinelli-Pignatelli. Era questo il nucleo nevralgico della primigenia struttura fortificata, eretta in epoca angioina (sec. XIV), ma rispondente ancora alla tipologia dei fortilizi romanici. Nel mastio si trovava il centro nevralgico della struttura, giacché la torre maestra era pensata come ultimo baluardo in caso di attacco nemico. L’accesso al mastio, infatti, non era diretto, ma attuabile solo attraverso un ponte levatoio. La feritoia del ponte levatoio, quella fenditura attraverso cui si distendevano e ritraevano catene e bolzoni per permettere abbassamento e sollevamento della passerella, è ancora visibile sulla faccia ovest del primo piano della torre. Per la sua conformazione difensiva, non esisteva neppure l’accesso, oggi a livello stradale, su piazza SS. Crocifisso, creato in pieno Ottocento. In origine si poteva raggiungere il piano terra, voltato a botte, solo attraverso una scaletta nella muraglia sud. Il mastio, di forma prismatica, è infatti impostato su due livelli, scanditi da un elegante cordolo marcapiano che divide appunto la scarpa del piano terra dal primo piano, dotato di un’ampia sala con volta a crociera ogivale (al posto del precedente: con ampia sala con volta a crociera ogivale). L’assetto originario della torre è reso noto dalla sua inserzione nei panorami galatei sottostanti vari dipinti seicenteschi, custoditi nelle chiese di Galatone. Una sua descrizione dettagliata è pure contenuta nell’“Apprezzo della terra di Galatone”, documento del 1734. Da queste testimonianze artistico-documentarie apprendiamo come fosse merlata e dotata di quattro torrette angolari in pietra. Essa era anche circondata da un fossato, colmato alla fine dell’Ottocento per recuperare superficie calpestabile. La torre, restaurata nel 1969, ospita fin da quella data la sede della Pro Loco.
Tornando al palazzo marchesale, la struttura fu eretta e modificata a più riprese nel corso dei secoli, dal medioevo all’età moderna. Il nucleo più antico risale al sec. XI, epoca dell’incastellamento di Galatone. La parte più vetusta visibile ad occhio nudo, però, è quella databile alla fine del sec. XII, tempo in cui signore feudale era tal Falcone. Si tratta delle opere murarie nei pressi dell’angolo sinistro del cortile. All’età sveva, sotto i signori Gentile, risalirebbero gli archi passanti a sesto acuto lungo le facce interne dell’edificio. Nuove strutture risalgono alla prima metà del sec. XIV, periodo di infeudazione ai Bellotto, che nel 1334 provvidero a consistenti fortificazioni urbiche. Interventi architettonici minori vennero curati dai feudatari di turno, lungo la fine del medioevo e i primordi dell’età moderna. Furono però i marchesi Pinelli, tra la fine del Cinquecento e la seconda metà del Seicento, a conferire un nuovo assetto al “castello” e a trasformarlo, a partire dal portale d’accesso e dalla facciata, in una prestigiosa dimora signorile moderna, degna del loro rango. In particolare, Cosimo Pinelli II edificò il piano nobile, con i suoi magnifici appartamenti, tra il 1670 e il 1680. Il palazzo subì ingenti danni il 20 febbraio del 1743, a causa del tremendo terremoto che in quella data colpì le contrade salentine.
Di proprietà degli eredi Pinelli-Pignatelli per i secoli a venire, il palazzo marchesale fu donato nel 1926 all’istituto religioso dei Terziari Cappuccini dell’Addolorata dal cardinale Gennaro Granito Pignatelli, ultimo discendente nel ramo maschile. Il porporato fu spinto alla pia donazione dalla sorella, la principessa Anna Granito Pignatelli. Ai frati fondati da mons. Luis Amigò, noti in paese come monaci spagnoli, toccarono così il palazzo marchesale in cui risiedettero con la loro comunità, il mastio e i possedimenti feudali nel rione San Luca, comprendenti all’incirca venti ettari di uliveto. Il palazzo e la torre rimasero di proprietà dei religiosi sino al 1981 quando vennero acquistati dal Comune di Galatone. Il restauro, intrapreso nel 1985, è stato condotto a più riprese fino al 2009, sotto la sapiente guida dell’architetto Giuseppe Resta. Un recente stanziamento di fondi fa sperare nel completamento definitivo dei lavori di conservazione e recupero.
Testi: Francesco Danieli